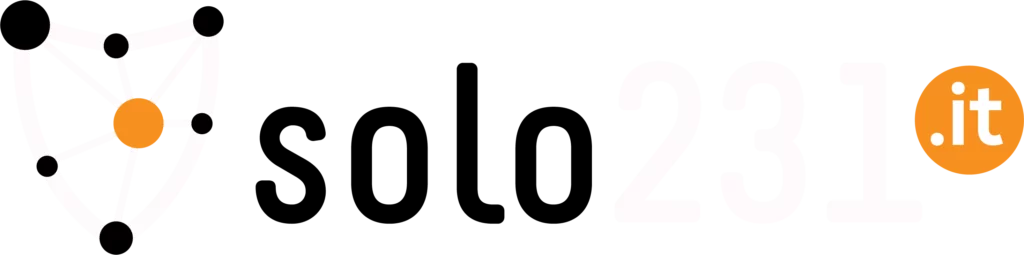La sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dei vertici della società è pienamente utilizzabile a fini probatori nel separato processo svolto nei confronti dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna.
Con la sentenza n. 24721/2024 la VI Sez. della Suprema Corte di cassazione torna ad occuparsi del tema relativo alla valenza probatoria a carico dell’ente della sentenza di patteggiamento degli imputati del reato presupposto, specificando come essa sia pienamente utilizzabile nell’ambito del procedimento de societate (svoltosi separatamente a quello nei confronti della persona fisica) come prova del fatto ivi accertato, a patto che ne sia confermata l’attendibilità attraverso ulteriori elementi di prova.
Con sentenza del 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Roma, in conferma della sentenza di primo grado, condannava una s.r.l alla sanzione pecuniaria in relazione all’illecito amministrativo dipendente dal delitto di corruzione commesso dal legale rappresentante e dall’amministratore di fatto della società (pur riconoscendo la circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 231 del 2001, per avere l’autore del reato commesso il fatto nel prevalente interesse proprio, senza che l’ente ne abbia tratto alcun vantaggio).
Avverso tale sentenza ricorreva l’ente a mezzo del proprio difensore deducendo diversi motivi, tra cui il travisamento dei fatti e delle prove e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza del reato presupposto di corruzione commesso dai vertici della società. Infatti, ad avviso del ricorrente quest’ultimo accertamento contenuto nella sentenza del giudice di prima cure si fondava solo ed esclusivamente sulla sentenza di “patteggiamento” emessa nell’ambito del procedimento penale svoltosi nei confronti dei soggetti apicali.
Ebbene, la Suprema Corte, ha ritenuto infondata la doglianza, evidenziando come la pronuncia impugnata indicasse, con motivazione congrua, le prove poste a fondamento della responsabilità dell’ente, le quali consistevano, non solo nella sentenza di patteggiamento degli apicali, ma – a conferma dell’attendibilità di quanto in essa accertato – anche in testimonianze di soggetti operanti, documenti e dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società.
Ciò premesso, relativamente alla valenza probatoria a carico dell’ente delle sentenze di patteggiamento degli imputati del reato presupposto, il Collegio ha precisato come queste siano pienamente utilizzabili nel procedimento de societate in base all’art. 238-bis del c.p.p. (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017) e possono senz’altro costituire prova circa la sussistenza del reato presupposto; conclusione questa derivante, secondo consolidata e pacifica giurisprudenza di legittimità, dalla espressa equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, contenuta nell’art. 445 c.p.p.
Occorre peraltro evidenziare come tale rapporto di sostanziale equiparazione tra patteggiamento e condanna sia rimasto invariato anche a seguito delle recenti modifiche apportate all’art. 445 c.p.p. dal D.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) che ha ivi introdotto il comma 1-bis, a norma del quale “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di legge, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444 comma 2 c.p.p. alla sentenza di condanna”.
Parimenti, la Suprema Corte ha ritenuto non meritevole di accoglimento anche l’ulteriore motivo di ricorso, con il quale l’ente contestava la sussistenza del requisito dell’interesse o vantaggio previsto dall’art. 5 del d.lgs. 231/2001.
Secondo il Collegio, infatti, la condotta corruttiva posta in essere dagli apicali era stata evidentemente realizzata al fine di consentire alla società di essere avvantaggiata nell’ottenimento dei pubblici appalti.
In forza di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente.
La sentenza in commento mette in evidenza tutte le problematiche che scaturiscono dall’art. 238-bis c.p.p.
Tale norma, infatti, rende particolarmente agevole l’accertamento circa la sussistenza del reato, costituendo un incentivo per il pubblico ministero a condurre separatamente i due procedimenti proprio al fine di acquisire la sentenza irrevocabile pronunciata nell’ambito del processo conclusosi per primo.
L’art. 238-bis c.p.p., inoltre, si pone in forte contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova, poiché – a differenza della norma immediatamente precedente, ossia l’art. 238 c.p.p. – consente la trasmigrazione di prove da un processo all’altro indipendentemente da un consenso dell’imputato o dal fatto che egli abbia partecipato alla relativa assunzione nel procedimento a quo.
Si tratta pertanto di subdolo espediente volto ad attenuare l’onere probatorio gravante in capo all’accusa e gettare un profondo stigma nel procedimento de societate rendendo altamente probabile la condanna dell’ente.
Tali criticità sono peraltro avvalorate dalla circostanza per cui, non solo le sentenze di condanna, ma anche quelle emesse al termine di un rito abbreviato o di patteggiamento (come avvenuto nel caso di specie) possono trasmigrare da un procedimento all’altro ed essere valutate con riferimento al fatto in esse accertato.
Occorre precisare come la Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 2009 abbia da tempo affermato, nonostante le suddette criticità, la compatibilità costituzionale della norma, sia in base al principio del libero apprezzamento del giudice, sia in forza del rinvio, in essa contenuto, all’art. 192, comma 3, c.p.p., ai sensi del quale la sentenza irrevocabile è valutabile solo in presenza di “riscontri esterni”, ossia di ulteriori elementi probatori che ne confermino l’attendibilità.
Proprio per tale ragione, specialmente in casi come questi in cui la sussistenza del reato presupposto è in re ipsa, l’ente potrà difendersi nel procedimento instaurato nei suoi confronti solo dimostrando l’assenza di una colpa di organizzazione.