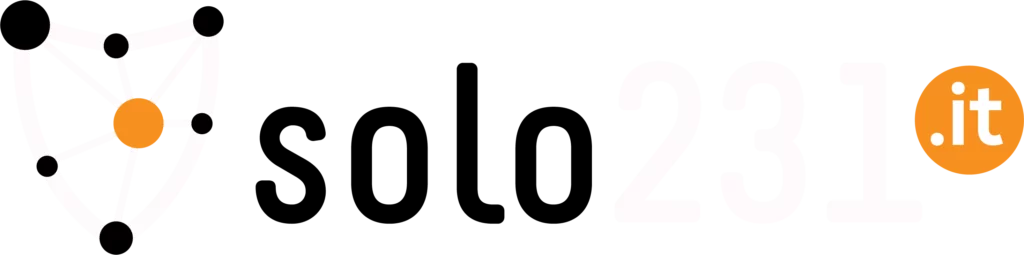La confisca nei confronti dell’ente, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 231/2001, non è rimesso alla disponibilità delle parti ed è irrilevante che non formi oggetto di accordo tra le parti, essendo certa la determinazione dei beni profitto da reato destinati all’ablazione e che la stessa è obbligatoria, quindi un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti, e di cui l’imputato deve comunque tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
La Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza n. 4753 del 29 gennaio 2025, ha chiarito questo importante principio in materia di confisca disposta ai sensi del d.lgs. 231/2001.
La vicenda traeva origine dalla decisione del GIP di Milano che, su richiesta delle parti, applicava la pena su richiesta delle parti al comproprietario ed al legale rappresentante di una Galleria la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro quattromila di multa per i reati di ricettazione e autoriciclaggio. Inoltre, alla Galleria d’arte si applicava la pena di euro cinquantaquattromila per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25-octies D.Lgs. 231/2001, ordinando la confisca del profitto del reato e dell’illecito amministrativo, quantificato in euro 750.000, ai sensi degli artt. 648-quater cod. pen. e 19 D. Lgs. 231/2001.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione. Si lamentava, in particolare, la violazione in relazione agli artt. 648-ter.1, 648-quater c.p. e 19 d.lgs. 231/2001 per errata individuazione del profitto del reato di autoriciclaggio.
Il provvedimento impugnato avrebbe errato in cui ritiene nel quantificare il profitto del reato, considerato coincidente all’ammontare della somma incassata dalla vendita del dipinto. Stando alla difesa, il profitto dell’autoriciclaggio va individuato nella plusvalenza che deriva dall’attività di sostituzione dei beni: la misura del profitto del reato di autoriciclaggio va determinata considerando solo l’effettivo incremento patrimoniale di cui abbia goduto il soggetto autore delle operazioni di autoriciclaggio.
Il profitto confiscabile è quello che rappresenta un risultato positivo, cioè un’utilità ulteriore rispetto a ciò che l’ente aveva prima della commissione dell’illecito, un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale pertinente al reato. La confisca non può colpire il patrimonio dell’autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione del reato.
Nel caso di specie, infatti, la condotta di autoriciclaggio è consistita nel rivendere ad un terzo il dipinto “natura morta” di Giorgio Morandi, a sua volta oggetto di precedente reato di furto e poi di ricettazione. La somma utilizzata per ricettare il dipinto costituisce trasformazione del provento del reato in cui l’imputato non concorse: la somma restante costituisce la plusvalenza ascrivibile al reato di autoriciclaggio.
La sentenza in commento ha evidenziato le differenze tra le nozioni di prodotto, profitto e prezzo del reato:
a) il prodotto del reato è costituito dalle cose create, trasformate o acquisite mediante esso, il risultato empirico del reato, che l’agente ottiene direttamente dalla attività posta in essere;
b) il profitto è il beneficio patrimoniale, l’utile, il vantaggio economico che si ricava dal reato;
c) il prezzo è costituito dal compenso o dall’utilità dati o promessi per la commissione del reato.
Vanno distinte la confisca disposta nei confronti dell’ente (la Galleria), sanzione per l’illecito amministrativo, da quella disposta nei confronti dell’imputato persona fisica, in caso di incapienza dell’ente.
La questione sottesa al caso affrontato dalla Suprema Corte è legato alla possibilità di disporre la confisca del prezzo e del profitto del reato nei confronti dell’ente con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), considerato che la norma prevede che la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato sia disposta con la sentenza di condanna.
Tale sentenza, come è noto, è equiparata alla sentenza di condanna.
L’art. 19 del D.lgs. n. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria sia del prezzo che del profitto del reato di autoriciclaggio, essendo tale reato contenuto nel catalogo di cui all’art. 25-octies D.lgs. 231/2001. Nel caso in esame, la somma di denaro oggetto della statuizione di confisca costituisce il profitto dell’attività di autoriciclaggio.
Si tratta di un cosiddetto reato-contratto, in quanto lo strumento negoziale ha costituito la sede di incontro delle volontà illecite. Infatti, qualora la legge qualifichi come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca.
Quando l’illecito penale si immedesima integralmente con il contratto concluso dalle parti, la confisca attinge l’intero ricavo da esso derivante, poiché non vi è alcuna ragione di operare una differenziazione ai fini della quantificazione del profitto rilevante rispetto ai costi sostenuti.
Il GIP ha correttamente disposto la confisca dell’intero ricavato dalla vendita del quadro (750.000 euro) e non solo del ricavato della alienazione, al netto dei costi sostenuti per l’acquisto della preziosa tela (470.000 euro).
Ulteriore tema meritevole di attenzione è quello della confiscabilità del prezzo o del profitto del reato ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 231/2001, nonostante tale aspetto non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità da reato degli enti, l’accordo delle parti, nel caso di patteggiamento, deve estendersi alla confisca così come a tutte le altre componenti sanzionatorie dell’illecito, la cui determinazione non può essere rimessa, nell’”an” e nel “quantum”, all’organo giudicante.
La confisca del profitto del reato in questi casi si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma, anche rispetto alle altre previste a carico dell’ente, con la conseguenza che non può non rientrare nell’accordo tra le parti.
Qualora il giudice ritenga che le parti sono addivenute all’erronea esclusione della confisca, dovrà rigettare l’accordo sulla pena: al contrario la decisione sulla confisca sarà rimessa alla determinazione al giudice, proprio perché così il patteggiamento risulterebbe parziale, non comprendendo tutte le sanzioni normativamente previste per l’illecito dell’ente.
La confisca è una sanzione non commisurata alla gravità della condotta o alla colpevolezza dell’autore: l’unico obiettivo è privare l’autore del beneficio economico tratto dall’illecito. Per tale ragione non è una circostanza rimessa alla disponibilità delle parti ed è irrilevante che non avesse formato oggetto dell’accordo tra le parti, essendo certa la determinazione dei beni profitto da reato destinati all’ablazione.
Inoltre si tratta di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti e di cui l’imputato – e la società – deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento.