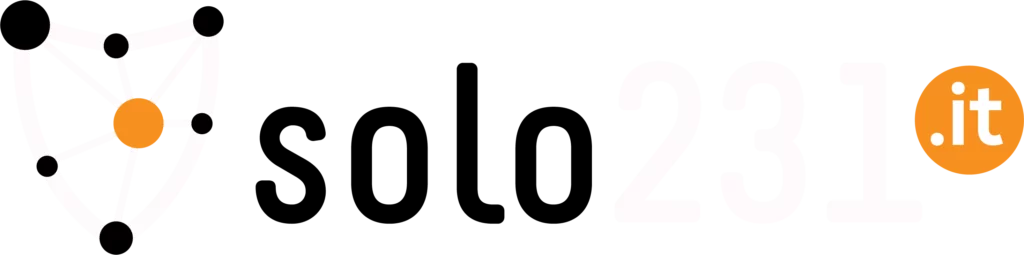Il Ministero della giustizia è coinvolto dal d.lgs. 231/2001 in qualità di autorità preposta all’approvazione dei codici di comportamento che, secondo il testo di legge (art. 6), possono essere “redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”, al fine di orientare gli associati nel procedimento di adozione dei modelli di organizzazione e gestione.
In particolare, l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, prevede che “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.
Nell’intento di offrire alle associazioni interessate un vademecum sia sulla prassi ministeriale in materia di validazione dei codici di comportamento, sia sul contenuto-forma dei predetti codici, secondo migliore scienza ed esperienza, assegnando uno specifico rilievo al tema della corruzione internazionale, con decreto del Capo di Gabinetto è stato costituito un apposito gruppo di lavoro. All’esito del confronto con i diversi interlocutori partecipi del gruppo, è stato elaborato un documento, recante “CRITERI GUIDA per la REDAZIONE di CODICI di COMPORTAMENTO delle ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE di ENTI”.
Il documento, infatti, si offre di fornire indicazioni e criteri guida alle associazioni rappresentative degli enti che possono adottare codici di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione e di gestione.
Da una parte, ha lo scopo di informare le associazioni rappresentative degli enti in merito ai criteri guida che orientano l’esame dei codici di comportamento comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 6 co. 3 del decreto; dall’altra parte, il documento si propone di delineare un quadro metodologico per la predisposizione e/o l’aggiornamento dei codici di comportamento da parte delle associazioni medesime, sempre ricordando, però, che la concreta scelta di dotarsi di un modello organizzativo e le modalità di implementazione sono di esclusiva pertinenza di ciascun ente.
L’opportunità di definire i criteri guida è fortemente legata all’evoluzione dell’elaborazione giurisprudenziale e al dato comparatistico.
La Corte di Cassazione, di recente, nel ribadire che tali codici non costituiscono una “regola organizzativa esclusiva ed esaustiva” e che il modello organizzativo deve essere “quanto più singolare possibile”, ha sottolineato come la procedura sia “funzionale da un lato, a fissare, attraverso le linee guida, parametri orientativi per le imprese nella costruzione del modello organizzativo; dall’altro, a temperare la discrezionalità del giudice nella valutazione dell’idoneità del modello stesso”.
Da ciò consegue che, “in presenza di un modello organizzativo conforme a quei codici di comportamento”, il giudice sarà tenuto specificamente a motivare le ragioni per le quali possa, ciò nonostante, ravvisarsi la colpa di organizzazione dell’ente.
Un ulteriore argomento, come anticipato, giunge dall’esperienza comparata, che offre casi di rilievo di documenti di fonte pubblica rivolti agli enti collettivi con funzione di indirizzo e di guida. Un settore di particolare interesse è quello del contrasto alla corruzione, in relazione al quale si ricordano le linee guida adottate dal Ministero della giustizia britannico in relazione al Bribery Act del 2010, sia i diversi documenti di orientamento elaborati dall’Autorità anticorruzione francese (AFA) nel quadro delle riforme introdotte dalla Loi Sapin II del 2016.
Il documento consta di due sezioni.
- Nella prima si ripercorrono le caratteristiche di fondo del d.lgs. n. 231/2001 e si approfondisce il contenuto dell’art. 6, co. 3; si analizza, altresì, la normativa di rango secondario e la procedura di approvazione dei codici di comportamento.
- Nella seconda, invece, si individuano i criteri guida che orientano l’esame dei codici di comportamento da parte del Ministero della giustizia.
La riforma introdotta con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è stata sollecitata dalla necessità di allineare il quadro normativo italiano agli obblighi discendenti dalla ratifica di alcuni atti internazionali, tra i quali la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 1997.
Come chiarito dalla Relazione di accompagnamento al decreto, ha offerto risposta all’esigenza di “colmare un’evidente lacuna normativa del nostro ordinamento”, anche in quanto analoghe forme di responsabilità erano, al tempo, “già una realtà in molti Paesi dell’Europa” ed essendo un dato fenomenologico acquisito che “molte pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa”.
Sulla base di tali premesse, il legislatore italiano ha delineato un autonomo sistema di responsabilità a carico di soggetti collettivi che prevede criteri di imputazione e conseguenze sanzionatorie distinti da quelli che caratterizzano il diritto penale della persona fisica.
Sul piano dell’attribuzione della responsabilità, il decreto identifica puntuali criteri oggettivi e soggettivi. Quanto al primo, affinché l’ente possa essere ritenuto responsabile, si richiede la commissione di un reato presupposto nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di una persona fisica – apicale o sottoposto- esponente dell’organizzazione.
Sul versante dell’imputazione soggettiva, invece, l’art. 6 del decreto rimanda alla nozione di “colpa di organizzazione”, pur disponendo che l’ente non può essere ritenuto responsabile se, prima del commissione del reato presupposto da parte del suo agente, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Come anticipato, il d.lgs. n. 231/2001 prevede il coinvolgimento del Ministero della Giustizia in quanto autorità preposta all’approvazione dei codici di comportamento che possono essere “redatti dalle associazioni rappresentative degli enti” al fine di orientare i soggetti associati nel procedimento di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione.
Secondo l’art. 5, che assegna la competenza in materia alla Direzione generale della giustizia penale (oggi Direzione generale degli affari interni), i codici di comportamento devono contenere “indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l’adozione e l’attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione” previsti dall’art. 6; inoltre, l’invio dei codici di comportamento deve essere “accompagnato dallo statuto e dall’atto costitutivo dell’associazione”, con la specifica che “in difetto, ovvero quando dall’esame di tali atti risulti che il richiedente è privo di rappresentatività, l’Amministrazione arresta il procedimento di controllo alla fase preliminare, dandone comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dei codici”.
Il Direttore generale degli affari interni esamina i codici di comportamento sulla base dei criteri fissati dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, potendo a tal fine avvalersi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio ministeriale, delle consulenze di esperti in materia di organizzazione aziendale. Entro trenta giorni dalla comunicazione del codice di comportamento, il Direttore generale può comunicare, previo concerto con i Ministeri competenti, eventuali osservazioni in merito alla idoneità dello stesso a fornire le indicazioni specifiche del settore per l’adozione e l’attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione finalizzati alla prevenzione dei reati c.d. presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente: laddove a seguito di osservazioni pervenga un codice aggiornato, ai fini di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni decorre nuovamente.
L’art. 7, co. 3, delinea poi un’ipotesi di silenzio-assenso, poiché, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.
In ogni caso, la conformità di un modello di organizzazione e gestione alle prescrizioni di codici di comportamento che abbia ricevuto l’approvazione del Ministero della giustizia non può mai assicurare, per ciò solo, il positivo esito della valutazione giudiziale e l’esonero da responsabilità per l’ente.
L’associazione interessata a ottenere l’approvazione del codice di comportamento è tenuta a dimostrare la propria legittimazione, esibendo lo statuto e l’atto costitutivo descrivendo compiutamente, i compiti a essa demandati nell’interesse degli enti rappresentati.
L’esibizione dello statuto e dell’atto costitutivo non occorre, laddove si tratti del mero aggiornamento di un codice di comportamento e laddove al contempo non sia sopravvenuta, nelle more della precedente approvazione, alcuna modificazione dello statuto.
Per quanto concerne la fase propriamente istruttoria e di valutazione del codice di comportamento, giova segnalare come il Ministero della Giustizia, nell’ottica di valorizzare la sinergia prevista dall’art. 7, d.m., abbia sempre chiesto ed acquisito il contributo dei seguenti Ministeri ed Autorità:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CONSOB – Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato;
- BANCA D’ITALIA – Unità di Informazione finanziaria per l’Italia – Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali – Divisione normativa e rapporti istituzionali;
- Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza – Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione IV – Ufficio VIII;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE) – Ufficio legislativo.
I codici di comportamento devono avere, a loro volta, un contenuto non meramente teorico, ma sufficientemente pratico-descrittivo, tale da lasciar comprendere quale debba essere, secondo miglior scienza ed esperienza, il contenuto dei modelli di organizzazione da adottare poi a cura di ciascun ente rappresentato.
Un primo ed essenziale aspetto che viene in considerazione attiene all’efficacia del codice di comportamento. L’effettiva utilità del codice medesimo, intesa come capacità di orientare il comportamento degli associati attraverso la predisposizione di linee guida sufficientemente chiare e suscettibili di essere prese a concreto riferimento per l’adozione del modello di organizzazione e gestione del singolo ente.
Un secondo indice da menzionare riguarda la specificità del codice di comportamento. È essenziale che tale codice delinei, con adeguato livello di dettaglio, il settore commerciale e/o l’ambito di operatività dei soggetti associati, dal momento che le indicazioni fornite devono essere “ritagliate” sulle peculiarità della categoria rappresentata.
L’obiettivo perseguito dai codici di comportamento deve essere, in questo contesto, quello di evitare la riproduzione di modelli di organizzazione caratterizzati da genericità e, quindi, non in grado di reggere al vaglio giudiziario.
Un ulteriore criterio di riferimento riguarda il connotato della dinamicità, da intendersi come capacità del codice di comportamento di fornire indicazioni non eccessivamente rigide, bensì in grado di intercettare un ampio novero di casistiche; indicazione che possano, dunque, essere adattate, nella trasposizione realizzata dai singoli enti nei propri modelli organizzativi, alle evoluzioni dei fenomeni da considerare e gestire.
I codici di categoria, come detto, hanno l’obiettivo anzitutto di orientare i comportamenti degli associati. In tale prospettiva, appare indispensabile che nel codice di comportamento sia ricompresa una sezione introduttiva che delinei, in modo chiaro e sufficientemente puntuale, i caratteri di fondo della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001, le finalità della stessa, l’apparato sanzionatorio, nonché le importanti funzioni – preventiva, di esonero, riparatoria – rivestite dai modelli di organizzazione e gestione nel quadro del decreto.
Quanto alle componenti da ricondurre alla parte generale del modello organizzativo che dovrebbero essere richiamate nei codici di comportamento – senza che ciò pregiudichi la possibilità, per le singole associazioni, di indicare componenti ulteriori e/o di dettagliare maggiormente quelli di seguito elencati – si ricordano:
– l’organizzazione e le caratteristiche operative delle singole realtà;
– l’individuazione dei destinatari del modello organizzativo;
– la metodologia seguita per la individuazione e gestione dei rischi (avuto riguardo, in particolare, alla costruzione del sistema di controllo e alla procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato);
– il Codice etico, che richiama l’insieme dei valori, dei diritti e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei c.d. portatori di interesse e che prescrive o vieta determinati comportamenti, prevedendo del caso sanzioni in rapporto alle violazioni (sistema disciplinare);
– l’Organismo di Vigilanza, previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, chiamato a vigilare sull’adozione dei modelli organizzativi da parte dell’organo dirigente a ciò preposto e sul loro funzionamento, sulla loro osservanza e sul loro aggiornamento.
I codici di comportamento devono fornire indicazioni riguardanti la composizione dell’Organismo di Vigilanza, il suo ruolo, le sue funzioni e i suoi poteri, i flussi informativi e il suo funzionamento operativo, i rapporti con gli altri organi di controllo; i canali di segnalazione interna (whistleblowing), in linea con le previsioni di fonte europea di cui alla direttiva (UE) 2019/1937; la comunicazione al personale e la sua formazione; il sistema di monitoraggio, i principi di controllo sul modello organizzativo e l’aggiornamento dello stesso. Le associazioni rappresentative devono altresì includere nei codici di comportamento – oppure chiarire le ragioni per le quali non occorre includere in relazione alla propria realtà di riferimento – specifiche indicazioni che consentano di adattare gli elementi sopra richiamati sulla base dei requisiti dimensionali dei soggetti associati (ad esempio, avuto riguardo ai gruppi e alle piccole imprese).
La parte speciale del modello organizzativo è la sede in cui trova attuazione l’attività di mappatura del rischio in relazione alle diverse fattispecie di reato presupposto rilevanti ex lege, e in cui sono quindi riportate le cautele finalizzate alla riduzione del rischio reato. Anche avuto riguardo agli elementi della parte speciale del modello organizzativo da includere nei codici di comportamento delle associazioni di categoria, si ribadisce che le indicazioni che seguono rappresentano uno standard minimo, che lascia aperta la possibilità per le associazioni rappresentative degli enti di prevedere elementi ulteriori o un maggior grado di dettaglio.
Tra le componenti della parte speciale del modello organizzativo si annoverano:
– la elencazione dei reati presupposto previsti dalla normativa e le correlate attività sensibili.
Sarebbe, inoltre, di ausilio per i singoli associati che i codici di comportamento individuino le aree di rischio reato più ricorrenti in relazione alla categoria rappresentata (ad esempio, considerando il settore commerciale e/o l’ambito di operatività degli enti rappresentati, l’ambito geografico di riferimento, le caratteristiche organizzative e la forma giuridica in prevalenza prescelta, precedenti dati o statistiche sul punto etc.);
– la metodologia per la costruzione della parte speciale del modello organizzativo, fornendosi agli enti rappresentati indicazioni riguardanti le principali e più consolidate modalità di costruzione di tale parte, ossia quella per fattispecie di reato presupposto e quella per processo. Come noto, la metodologia che muove dalle ‘famiglie’ di reato prevede che si esaminino le singole fattispecie e le relative modalità di integrazione, che si identifichino le aree di rischio e le concrete possibilità, in rapporto all’attività del dato ente, di commissione di quei reati, e che si individuino gli standard di controllo.
L’utilità e la chiarezza delle linee guida illustrate verrà valutata dalle associazioni rappresentative degli enti, ma di sicuro quello ad oggi continua a mancare è la conoscenza e l’attuazione della normativa in esame in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.
Sebbene, infatti, siano passati più di venti anni dall’entrata in vigore della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, la sensazione è che se ne parli ancora poco e nel modo meno giusto, poco chiaro e poco fruibile dalla maggioranza delle imprese italiane.
La realtà imprenditoriale e aziendale italiana è una delle più grandi al mondo, per incidenza sul piano economico e per qualità dei servizi offerti, ma è ancora lontana da quel livello di sicurezza che ci si aspettava di raggiungere con la disciplina 231.
Fino a quando l’Impresa non prenderà consapevolezza della reale importanza dell’adeguamento alla normativa in esame, facendo proprio il canone “è meglio prevenire che curare”, gli operatori del diritto in questo settore rimarranno dei “venditori”, spesso anche fastidiosi, di un servizio di cui si farebbe volentieri a meno.